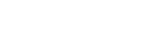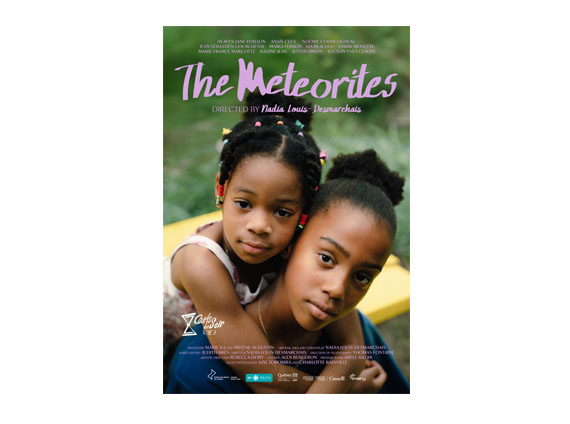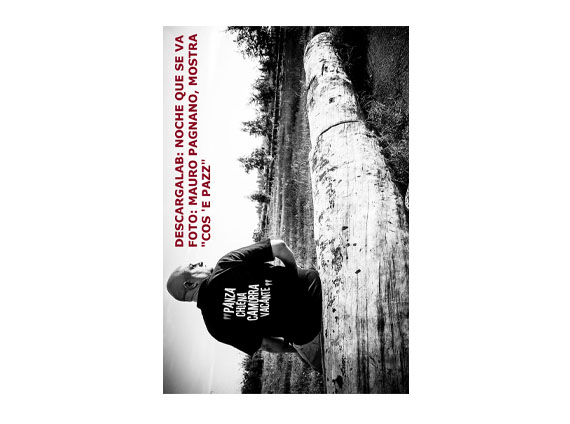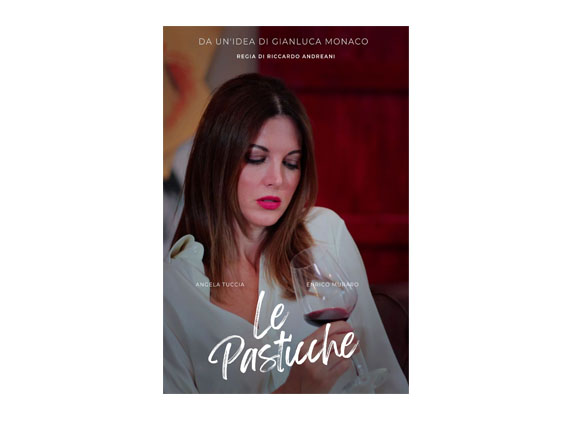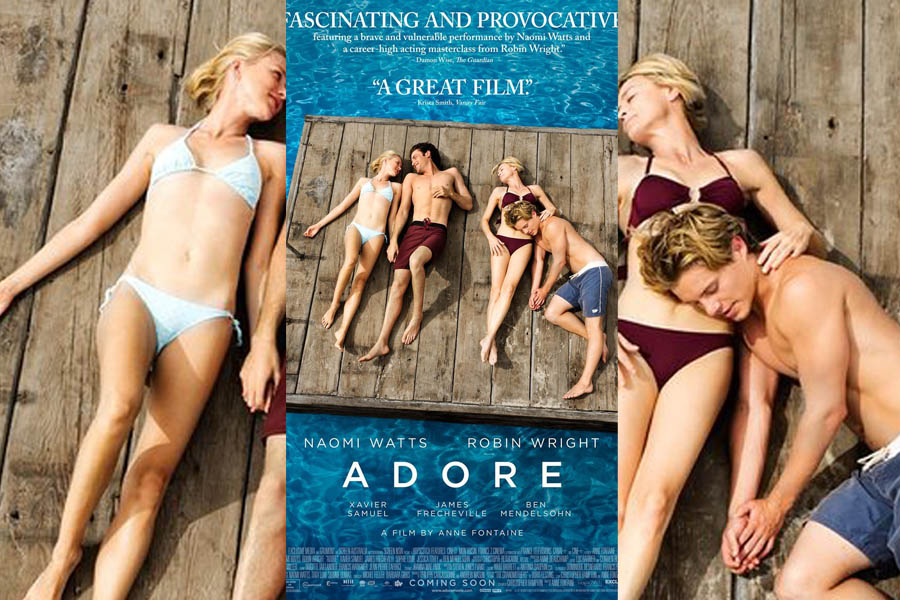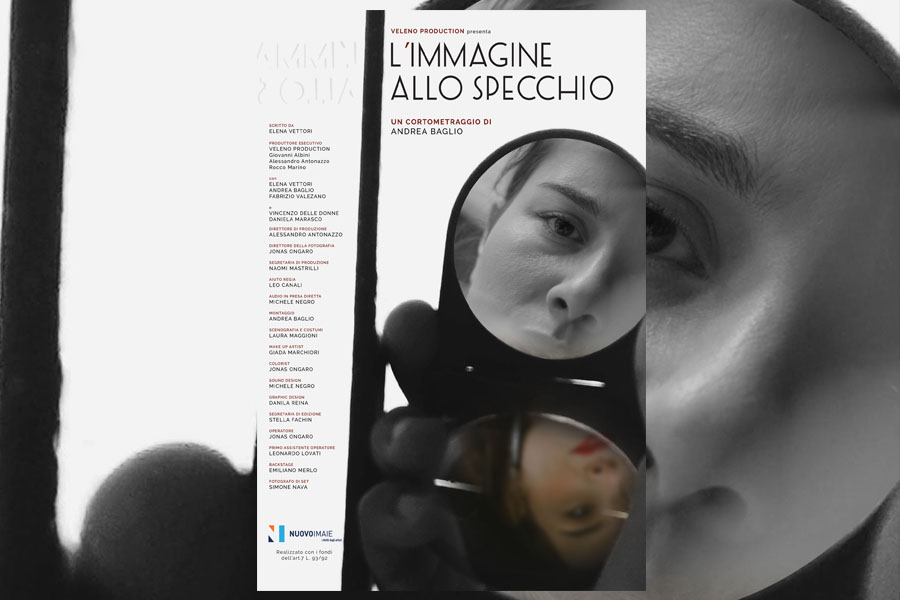Il papa afferma: il Vaticano è corrotto
- Blog
- Visite: 2448
Di Silvia Di Biagio
Per la prima volta un papa ha affermato la verità; il Vaticano è corrotto. È da notare la semplicità del suo discorso e anche il coraggio di denunciare qualcosa che si è sempre saputo ma sempre tenuto nascosto e negato. La cosa che colpisce è che lui dice di essere salvo, non si sente minimamente coinvolto in quanto vive in modo dignitoso e nel rispetto degli altri.
Uno dei problemi principali è la pedofilia che è considerata una vera e propria malattia. Oltre a questi casi molto diffusi qualche giorno fa è andato in onda un servizio che documentava la folle notte di un parroco. Si era recato in un nightclub in cerca di prostitute spendendo centinaia di euro che sicuramente provenivano dalla raccolta dei fedeli.
La tranquillità che il parroco ha avuto al riguardo ci colpisce molto, come se il suo gesto fosse una cosa da tutti i giorni.
Sicuramente il papa non può più tollerare questi avvenimenti poiché la Chiesa deve essere un esempio per la comunità, un luogo in cui si insegna a donare e aiutare chi ne ha bisogno, non un luogo dove i primi a non avere un atteggiamento dignitoso sono coloro che la rappresentano.
La Chiesa anche in passato aveva i suoi problemi; nel IX e X secolo era particolarmente corrotta, molti vescovi diventavano funzionari pubblici o potenti feudatari e vendevano i sacramenti. Nei loro confronti c'erano accuse di simonia, concubinato e di comportamenti immorali. Spesso era discussa anche la figura del papa che non era vista come una persona autorevole sia dal punto di vista spirituale che politico. Proprio per questo nacquero nuovi ordini monastici come quello dei cluniacensi e dei certosini per un profondo rinnovamento della Chiesa, predicando un ritorno alla purezza e alla povertà, ma coloro che lottavano per una Chiesa migliore venivano considerati eretici. Per non parlare del periodo della Controriforma con il tribunale dell'Inquisizione usato come strumento di repressione, ma anche per garantire un ordine nella società; le vittime principali furono le donne: quando iniziò la caccia alle streghe e vennero colpite tutte coloro che non seguivano i canoni di vita medievali.
Quindi sin dal Medioevo abbiamo una Chiesa corrotta e nessun membro che ne faceva parte l'aveva mai dichiarato, forse perché nessuno è mai stato veramente interessato al ruolo importante che dovrebbe rappresentare.